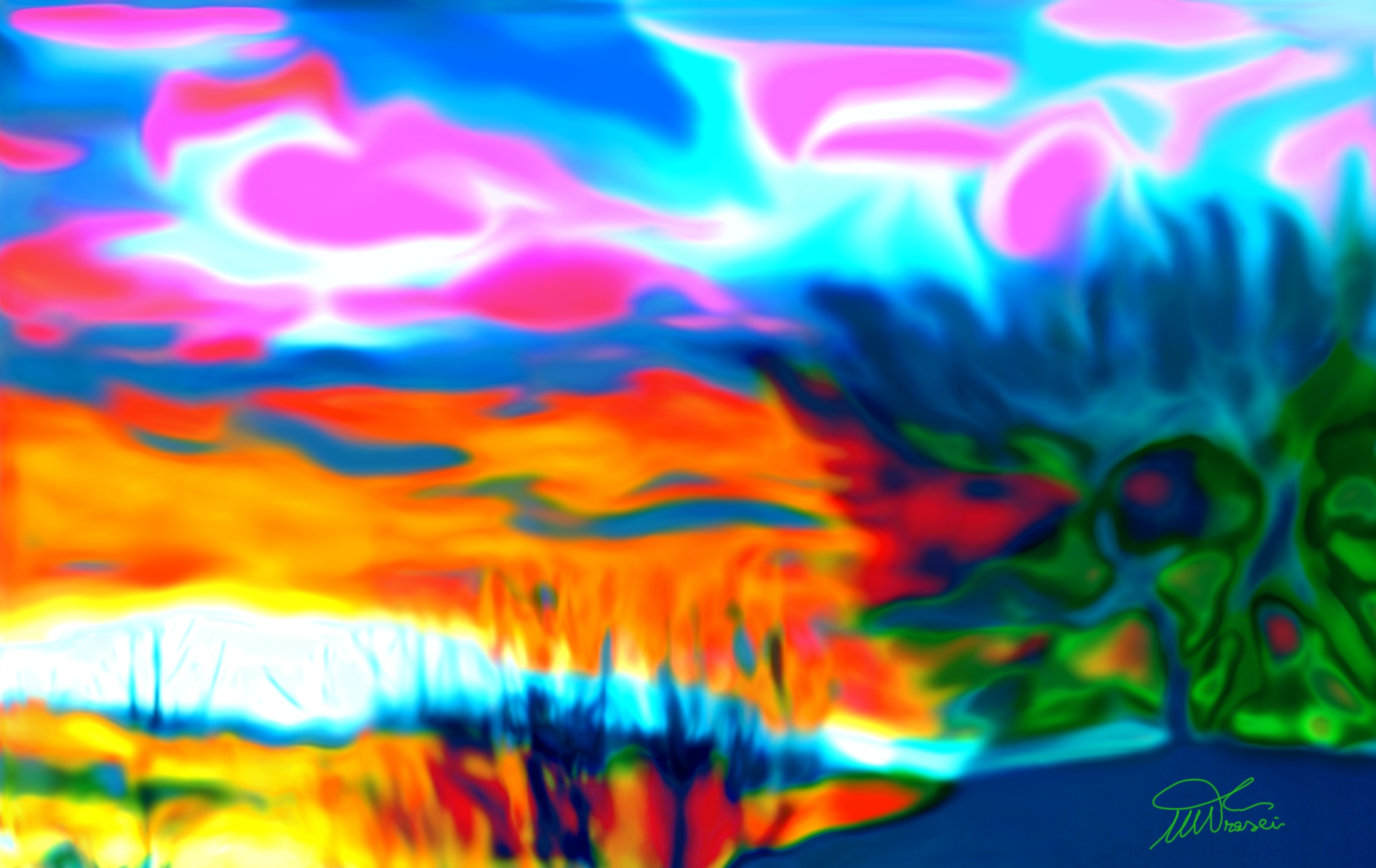Prose
Fiumi di parole
(2)
Incipit d'autore
(1)
Io e te
(1) Il viaggio
Le mie stanze
(41) Assenze d'esistenza
Testi Canzoni
(133)
Raccolta: Le mie stanze
Prima o poi
27 giugno 2010
Nessuno è tanto megalomane da definirsi scrittore, bravo e meno bravo che sia, ma ognuno di noi ha con sé una storia che, almeno una volta nella vita, gli ha fatto esclamare: “Prima o poi ne farò un libro”. Di solito capita sempre di gridarla, o sussurrarla, a secondo del carattere che abbiamo, nel momento più duro, in quello dove, con le mani di un’anima sanguinante, continui a scavare dentro te stesso alla ricerca di un briciolo di speranza, o di ravvisarne almeno l’odore, il resto di un profumo che la sofferenza del tempo ha sniffato fino all’esaurimento per drogarsi di luce, di un domani del pensiero ancora da vivere con attesa per le meraviglie che la vita ti darà. Allora scavi e sterri, affondi e sollevi, giri e rivolti i pensieri fino alla costruzione della follia, che è illusione, sogno, desiderio, ipotesi, o forse solo il fantasma di una speranza che vuoi a tutti i costi viva dentro di te per non lasciarti andare come morto all’esistenza. I motivi sono miliardi, tali e tanti come le vite degli individui. Alcuni fulminei e tragici, altri lunghi e logoranti. Per ognuna di queste vite è la fine di qualcosa, di un sorriso, di una gioia, di un amore, di un lavoro, di una casa, di un ideale. Per ciascuno di noi è la perdita di sé, lo smarrimento dell’identità, la distruzione di un progetto di vita: “Una morte”. Vi siete mai chiesti quante volte possiamo morire? Io si. Tutte le volte che in realtà mi è toccato buttarmi via dopo essere stata strappata in mille pezzetti da qualche evento, da qualche pessimo individuo, da qualche accidente non previsto capitato ai miei giorni. Però così come si muore, altrettante volte si rinasce, o perlomeno, ne hai l’illusione. C’è quella forza strana degli uomini, probabilmente legata ad un innato istinto di sopravvivenza, che gli consente di ricominciare a vivere per innumerevoli volte nella medesima vita. Un evento sorprendente, inspiegabile razionalmente. In fondo non vale la pena darsene ragione, le troppe interrogazioni cerebrali richiedono la disponibilità di una energia che, il morto, in fase di rinascita non possiede. Il suo respiro è minimo, gli basta appena a restar vivo. Al contrario della morte esistenziale, alla quale per verificarsi, come dicevo prima, occorrono eventi fulminei e tragici, oppure, lunghi, logoranti e diversificati nel tempo, per la rinascita alla vita esistenziale basta molto meno, è sufficiente ritrovare ancora palpitante in se stessi un poco di speranza. Non importa che sia rivolta al mondo della natura, o al mondo degli uomini, o anche soltanto a una scimmietta abbarbicata a quella piccola liana dove la nostra identità ci appare forte, robusta, ancora in grado di lottare per l’affermazione dell’io, l’importante è ravvisarne l’esistenza in qualcosa fuori di noi o dentro noi, allora si, il gioco è fatto. Possiamo dirci salvi. Liberi di non udire più quel sibilo angosciante che fruscia alle orecchie dello spirito con blasfemia e volgarità queste parole: “Ma che cazzo ci campo a fare in questo mondo di merda”. E’ nell’andare vorticoso di questo morire e nascere, di questo essere uccisi dalla socialità e di ritrovare vita nell’individualità che il pensiero umano cresce sondando terreni folli e fertili di genialità. Ore, mesi ed anni di vita che i morti viventi, o i viventi morti, trascorrono pensando, parlando a se stessi, domandando e rispondendo ai mille quesiti dell’essere e dell’avere che si contrappongono e si pongono al mondo che ci circonda. Proprio in questa fase riflessiva capita che prenda corpo la balzana idea di scrivere. Sei lì, circondato da miliardi di fazzoletti di carta che non sono riusciti ad accogliere il muco che ancora cola imperterrito giù dal naso, hai gli occhi strabuzzati di fuori, rossi di sangue e, quando vai in bagno a lavarti la faccia, con l’intento di cavarti via, insieme alle lacrime versate, anche il dolore che ancora senti dentro forte ed impetuoso, demoralizzato, ti accorgi che non è servito piangere per due ore con la speranza di cacciarlo via, no, lui è ancora lì. Ti guardi ed esclami: “Mio Dio, ma quella chi è?”. Ti lavi, ti mondi, ti asciughi il viso e ti risoffi il naso per la milionesima volta. Le braccia si muovono a fatica, quasi avessero arato campi per vent’anni, e la schiena ti pare sia quella di un detenuto condannato ai lavori forzati per l’ergastolo. Esci dal bagno, gironzoli senza meta per le stanze, le attraversi una ad una, ti guardi intorno cercando la salvezza della vita in qualche oggetto, ma non la trovi, anzi, se ti imbatti in qualche ricordo, ti tocca ricominciare la lacrimazione che se ne fotte della tua volontà di non piangere, se ne sbatte del tuo desiderio di rinascere, lei, ora vorrebbe solo morire fuori, anche in quel corpo che si ostina a vivere nonostante dentro abbia solo la morte. Ricominci. Provi ad avere un pensiero libero che non sia manovrato e condizionato da quel dolore che ormai non ha più parole sensate, cammina dentro la tua testa con frasi sconnesse e immagini di un qualcosa che in quel momento hanno senso solo per te. Ti agiti ansimante, singhiozzante, con gli occhi che non vedono oltre il dolore, apri cassetti cerchi una penna, un pezzo di carta, un miserabile straccio di legno che possa accogliere l’assurdità di questa tua interiorità, solo questa parola ha un chiaro significato: Scrivere, scrivere, scrivere… perché è ingiusto che il mondo continui ad esistere ignorando quello che tu vivi.
28 giugno 2010
Cerchi tra le cose del tuo mondo esteriore, il più prossimo alle esperienze e ai sentimenti della tua vita e finalmente lo trovi quel microscopico lenzuolo nel quale segnare il tuo dolore e ti accontenti di imprimerlo con l’inchiostro, mentre in realtà vorresti imbrattarlo del tuo sangue, perché questo sono le parole che stai per scrivere, sono il tuo sangue, il fluire ineluttabile della tua morte che nessuno vede e solo tu puoi piangere. Continui la ricerca, ti guardi intorno per stabilire dove abbandonare le funebri spoglie che si muovono ancora agonizzanti alla coscienza allucinante di una verità conflittuale che ti costringe all’accettazione del tuo doppio, c’è qualcosa di morto dentro che guerreggia con quel tuo qualcosa ancora vivo fuori. E la trovi la fossa dove seppellirti, potrebbe essere una poltrona accanto alla scrivania, ma passi per la cucina perché piangere ti ha messo sete e mentre apri il frigo attaccandoti alla bottiglia guardi la sedia discosta dal tavolo e ti ci abbandoni sfinita. Il grido bianco del foglio e la nera lacrima della penna in punta sono lì, li guardi e sai che ognuno dei due attende l’azione dell’altro. Lui è pronto ad accogliere, lei straripante del desiderio di donare. Li fissi per un tempo indeterminato, incalcolabile, e aspetti il pensiero che fino a pochi istanti prima era turbolento e prolisso, mentre ora tace. Caput, sparito, finito, anche lui morto e sepolto. Dileguatosi il malandrino che poco prima ti ha inferto migliaia di pugnalate ora ti senti sola, solissima, abbandonata anche da te stessa, frastornata da queste domande: “Ma perché sono qui? Per quale motivo soffro e piango? Cosa dovrei scrivere? In realtà io chi sono? Chi mi ha portato a questo sentire? Non risponde nessuno, solo il silenzio ti ispira altro silenzio in ore di fissazioni alle pareti, alle porte, al mobilio, agli oggetti che vuoi riconoscere ed invece non ti comunicano che estraneità. Rimani con il vuoto a stancarti del tuo vuoto fino allo stremo, fino all’indifferenza, alla sopraffazione del sonno che ti porta nel letto o sul divano, o piuttosto accovacciata in una poltrona del salotto, ed amen. Un sonno della vita parodia e pessima copia del sonno eterno. Ti pare di dormire, in effetti è solo il tuo corpo che reagisce allo stress del troppo soffrire e del troppo piangere, come se ti dicesse: Ehi bimba, ora basta. Non ti pare che stai esagerando? Io sono stanco, tutte sté manfrine mi hanno distrutto, questi problemi non si risolvono oggi, dammi tregua, fammi prendere fiato, ne riparliamo fra qualche oretta ok? Questo stato comatoso è in effetti la tua salvezza, il tuo reparto di rianimazione, la tua stanza imbottita da nosocomio, perché è ora che incominci a percorrere, in maniera obiettiva, la strada a ritroso di tutte le esperienze e di tutte le emozioni di cui sei stata protagonista. Con le palpebre abbassate come le saracinesche chiuse dal mondo in un giorno di lutto nazionale la tua identità comincia a muoversi circospetta tra le ombre e i chiaroscuri degli scaffali. Deambuli a tentoni, con le braccia ben protese in avanti e le mani aperte intente a sfiorare, toccare, manipolare gli oggetti che incontrano, sforzando e spingendo la memoria ad un recupero ad un riconoscimento sincero e corretto di ogni piccolo frammento che hai dentro, che sei stata, che ti fa quello che sei. Al buio di te stessa la percezione è limitata e allo stesso tempo amplificata, come se altre facoltà d’analisi insite nella mente dell’uomo uscissero allo scoperto protette dall’anonimato. Prima timidamente, tanto impacciate che non fai in tempo a coglierle razionalmente, poi a mano a mano più sfacciate, più impudiche sostano con immagini agli occhi e con parole alla mente per più tempo dandoti modo di afferrarle. Non le comprendi. Quello che ti arriva è privo di significato, eppure, mette in moto un meccanismo di interrogazioni che ti avvia al discorso interiore. Stai parlando nuovamente a te stessa, il vuoto comincia a riempirsi di vecchio con il faticoso dovere di costruire il nuovo che sarai. Ne hai di lavoro da fare bimba! Stavolta senza distrazioni, senza alterazioni del sentito, dovrai dirti la verità. Non avrai un ordine cronologico dell’analisi, afferrerai quel che capita di te stessa e lo inseguirai nelle emozioni che riporta, nelle domande che susciterà al tuo oggi, e dovrai risponderti, dovrai dirtela la verità. Cazzo! Mio padre non mi ha amata ed io ci sono stata da cane. Porca miseria! Mia madre è stata con me come la matrigna per cenerentola. Accidenti al mondo! Non mi ha mai accettata per come ero. Stronzo d’un uomo! Mi ha usata è buttata via come un fazzolettino di carta con il quale si è nettato il deretano. Bestia di una umanità! Che non rispetti i sentimenti e gli ideali degli uomini che hanno dentro la mansuetudine e la pace. Ecco ora si che puoi smettere d’odiarti, dirti che non è colpa tua, che non sei tu l’errore del mondo, ora puoi arrabbiarti non più con te stessa ma con tutto l’altro di te stessa, quello che il mondo ti ha messo dentro ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, dolore dopo dolore. Ora, puoi cacciarlo via l’inadeguato, l’ingiusto, il cattivo, l’indifferente, l’opprimente, il falso che non ti appartiene, quei sassi che ti affondano, lanciati alla profondità del tuo io dall’egoismo racchiuso nelle mani degli altri. Liberatene bimba. Lasciati dentro solo ciò che ti appartiene, solamente il bene ed il male generato da te, certa di poterti giustificare, perché se ora soffri e piangi hai un valido motivo, grande quanto le ingiustizie del mondo. Gridalo bimba. Ti prenderanno per matta, avrai un baratro di distanza fra te ed il resto, ma non importa, tu segnalo, incidilo, registralo, scrivilo, per non dimenticarlo, per non seppellirlo insieme alle tante morti con cui ti sei tumulata, fa che la voce ritorni come dall’oltretomba all’udire di miliardi di vite, finte illusioni d’esistenza, morti con te per le stesse ragioni, vivi come te nelle prigioni del silenzio.
Nessuno è tanto megalomane da definirsi scrittore, bravo e meno bravo che sia, ma ognuno di noi ha con sé una storia che, almeno una volta nella vita, gli ha fatto esclamare: “Prima o poi ne farò un libro”. Di solito capita sempre di gridarla, o sussurrarla, a secondo del carattere che abbiamo, nel momento più duro, in quello dove, con le mani di un’anima sanguinante, continui a scavare dentro te stesso alla ricerca di un briciolo di speranza, o di ravvisarne almeno l’odore, il resto di un profumo che la sofferenza del tempo ha sniffato fino all’esaurimento per drogarsi di luce, di un domani del pensiero ancora da vivere con attesa per le meraviglie che la vita ti darà. Allora scavi e sterri, affondi e sollevi, giri e rivolti i pensieri fino alla costruzione della follia, che è illusione, sogno, desiderio, ipotesi, o forse solo il fantasma di una speranza che vuoi a tutti i costi viva dentro di te per non lasciarti andare come morto all’esistenza. I motivi sono miliardi, tali e tanti come le vite degli individui. Alcuni fulminei e tragici, altri lunghi e logoranti. Per ognuna di queste vite è la fine di qualcosa, di un sorriso, di una gioia, di un amore, di un lavoro, di una casa, di un ideale. Per ciascuno di noi è la perdita di sé, lo smarrimento dell’identità, la distruzione di un progetto di vita: “Una morte”. Vi siete mai chiesti quante volte possiamo morire? Io si. Tutte le volte che in realtà mi è toccato buttarmi via dopo essere stata strappata in mille pezzetti da qualche evento, da qualche pessimo individuo, da qualche accidente non previsto capitato ai miei giorni. Però così come si muore, altrettante volte si rinasce, o perlomeno, ne hai l’illusione. C’è quella forza strana degli uomini, probabilmente legata ad un innato istinto di sopravvivenza, che gli consente di ricominciare a vivere per innumerevoli volte nella medesima vita. Un evento sorprendente, inspiegabile razionalmente. In fondo non vale la pena darsene ragione, le troppe interrogazioni cerebrali richiedono la disponibilità di una energia che, il morto, in fase di rinascita non possiede. Il suo respiro è minimo, gli basta appena a restar vivo. Al contrario della morte esistenziale, alla quale per verificarsi, come dicevo prima, occorrono eventi fulminei e tragici, oppure, lunghi, logoranti e diversificati nel tempo, per la rinascita alla vita esistenziale basta molto meno, è sufficiente ritrovare ancora palpitante in se stessi un poco di speranza. Non importa che sia rivolta al mondo della natura, o al mondo degli uomini, o anche soltanto a una scimmietta abbarbicata a quella piccola liana dove la nostra identità ci appare forte, robusta, ancora in grado di lottare per l’affermazione dell’io, l’importante è ravvisarne l’esistenza in qualcosa fuori di noi o dentro noi, allora si, il gioco è fatto. Possiamo dirci salvi. Liberi di non udire più quel sibilo angosciante che fruscia alle orecchie dello spirito con blasfemia e volgarità queste parole: “Ma che cazzo ci campo a fare in questo mondo di merda”. E’ nell’andare vorticoso di questo morire e nascere, di questo essere uccisi dalla socialità e di ritrovare vita nell’individualità che il pensiero umano cresce sondando terreni folli e fertili di genialità. Ore, mesi ed anni di vita che i morti viventi, o i viventi morti, trascorrono pensando, parlando a se stessi, domandando e rispondendo ai mille quesiti dell’essere e dell’avere che si contrappongono e si pongono al mondo che ci circonda. Proprio in questa fase riflessiva capita che prenda corpo la balzana idea di scrivere. Sei lì, circondato da miliardi di fazzoletti di carta che non sono riusciti ad accogliere il muco che ancora cola imperterrito giù dal naso, hai gli occhi strabuzzati di fuori, rossi di sangue e, quando vai in bagno a lavarti la faccia, con l’intento di cavarti via, insieme alle lacrime versate, anche il dolore che ancora senti dentro forte ed impetuoso, demoralizzato, ti accorgi che non è servito piangere per due ore con la speranza di cacciarlo via, no, lui è ancora lì. Ti guardi ed esclami: “Mio Dio, ma quella chi è?”. Ti lavi, ti mondi, ti asciughi il viso e ti risoffi il naso per la milionesima volta. Le braccia si muovono a fatica, quasi avessero arato campi per vent’anni, e la schiena ti pare sia quella di un detenuto condannato ai lavori forzati per l’ergastolo. Esci dal bagno, gironzoli senza meta per le stanze, le attraversi una ad una, ti guardi intorno cercando la salvezza della vita in qualche oggetto, ma non la trovi, anzi, se ti imbatti in qualche ricordo, ti tocca ricominciare la lacrimazione che se ne fotte della tua volontà di non piangere, se ne sbatte del tuo desiderio di rinascere, lei, ora vorrebbe solo morire fuori, anche in quel corpo che si ostina a vivere nonostante dentro abbia solo la morte. Ricominci. Provi ad avere un pensiero libero che non sia manovrato e condizionato da quel dolore che ormai non ha più parole sensate, cammina dentro la tua testa con frasi sconnesse e immagini di un qualcosa che in quel momento hanno senso solo per te. Ti agiti ansimante, singhiozzante, con gli occhi che non vedono oltre il dolore, apri cassetti cerchi una penna, un pezzo di carta, un miserabile straccio di legno che possa accogliere l’assurdità di questa tua interiorità, solo questa parola ha un chiaro significato: Scrivere, scrivere, scrivere… perché è ingiusto che il mondo continui ad esistere ignorando quello che tu vivi.
28 giugno 2010
Cerchi tra le cose del tuo mondo esteriore, il più prossimo alle esperienze e ai sentimenti della tua vita e finalmente lo trovi quel microscopico lenzuolo nel quale segnare il tuo dolore e ti accontenti di imprimerlo con l’inchiostro, mentre in realtà vorresti imbrattarlo del tuo sangue, perché questo sono le parole che stai per scrivere, sono il tuo sangue, il fluire ineluttabile della tua morte che nessuno vede e solo tu puoi piangere. Continui la ricerca, ti guardi intorno per stabilire dove abbandonare le funebri spoglie che si muovono ancora agonizzanti alla coscienza allucinante di una verità conflittuale che ti costringe all’accettazione del tuo doppio, c’è qualcosa di morto dentro che guerreggia con quel tuo qualcosa ancora vivo fuori. E la trovi la fossa dove seppellirti, potrebbe essere una poltrona accanto alla scrivania, ma passi per la cucina perché piangere ti ha messo sete e mentre apri il frigo attaccandoti alla bottiglia guardi la sedia discosta dal tavolo e ti ci abbandoni sfinita. Il grido bianco del foglio e la nera lacrima della penna in punta sono lì, li guardi e sai che ognuno dei due attende l’azione dell’altro. Lui è pronto ad accogliere, lei straripante del desiderio di donare. Li fissi per un tempo indeterminato, incalcolabile, e aspetti il pensiero che fino a pochi istanti prima era turbolento e prolisso, mentre ora tace. Caput, sparito, finito, anche lui morto e sepolto. Dileguatosi il malandrino che poco prima ti ha inferto migliaia di pugnalate ora ti senti sola, solissima, abbandonata anche da te stessa, frastornata da queste domande: “Ma perché sono qui? Per quale motivo soffro e piango? Cosa dovrei scrivere? In realtà io chi sono? Chi mi ha portato a questo sentire? Non risponde nessuno, solo il silenzio ti ispira altro silenzio in ore di fissazioni alle pareti, alle porte, al mobilio, agli oggetti che vuoi riconoscere ed invece non ti comunicano che estraneità. Rimani con il vuoto a stancarti del tuo vuoto fino allo stremo, fino all’indifferenza, alla sopraffazione del sonno che ti porta nel letto o sul divano, o piuttosto accovacciata in una poltrona del salotto, ed amen. Un sonno della vita parodia e pessima copia del sonno eterno. Ti pare di dormire, in effetti è solo il tuo corpo che reagisce allo stress del troppo soffrire e del troppo piangere, come se ti dicesse: Ehi bimba, ora basta. Non ti pare che stai esagerando? Io sono stanco, tutte sté manfrine mi hanno distrutto, questi problemi non si risolvono oggi, dammi tregua, fammi prendere fiato, ne riparliamo fra qualche oretta ok? Questo stato comatoso è in effetti la tua salvezza, il tuo reparto di rianimazione, la tua stanza imbottita da nosocomio, perché è ora che incominci a percorrere, in maniera obiettiva, la strada a ritroso di tutte le esperienze e di tutte le emozioni di cui sei stata protagonista. Con le palpebre abbassate come le saracinesche chiuse dal mondo in un giorno di lutto nazionale la tua identità comincia a muoversi circospetta tra le ombre e i chiaroscuri degli scaffali. Deambuli a tentoni, con le braccia ben protese in avanti e le mani aperte intente a sfiorare, toccare, manipolare gli oggetti che incontrano, sforzando e spingendo la memoria ad un recupero ad un riconoscimento sincero e corretto di ogni piccolo frammento che hai dentro, che sei stata, che ti fa quello che sei. Al buio di te stessa la percezione è limitata e allo stesso tempo amplificata, come se altre facoltà d’analisi insite nella mente dell’uomo uscissero allo scoperto protette dall’anonimato. Prima timidamente, tanto impacciate che non fai in tempo a coglierle razionalmente, poi a mano a mano più sfacciate, più impudiche sostano con immagini agli occhi e con parole alla mente per più tempo dandoti modo di afferrarle. Non le comprendi. Quello che ti arriva è privo di significato, eppure, mette in moto un meccanismo di interrogazioni che ti avvia al discorso interiore. Stai parlando nuovamente a te stessa, il vuoto comincia a riempirsi di vecchio con il faticoso dovere di costruire il nuovo che sarai. Ne hai di lavoro da fare bimba! Stavolta senza distrazioni, senza alterazioni del sentito, dovrai dirti la verità. Non avrai un ordine cronologico dell’analisi, afferrerai quel che capita di te stessa e lo inseguirai nelle emozioni che riporta, nelle domande che susciterà al tuo oggi, e dovrai risponderti, dovrai dirtela la verità. Cazzo! Mio padre non mi ha amata ed io ci sono stata da cane. Porca miseria! Mia madre è stata con me come la matrigna per cenerentola. Accidenti al mondo! Non mi ha mai accettata per come ero. Stronzo d’un uomo! Mi ha usata è buttata via come un fazzolettino di carta con il quale si è nettato il deretano. Bestia di una umanità! Che non rispetti i sentimenti e gli ideali degli uomini che hanno dentro la mansuetudine e la pace. Ecco ora si che puoi smettere d’odiarti, dirti che non è colpa tua, che non sei tu l’errore del mondo, ora puoi arrabbiarti non più con te stessa ma con tutto l’altro di te stessa, quello che il mondo ti ha messo dentro ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, dolore dopo dolore. Ora, puoi cacciarlo via l’inadeguato, l’ingiusto, il cattivo, l’indifferente, l’opprimente, il falso che non ti appartiene, quei sassi che ti affondano, lanciati alla profondità del tuo io dall’egoismo racchiuso nelle mani degli altri. Liberatene bimba. Lasciati dentro solo ciò che ti appartiene, solamente il bene ed il male generato da te, certa di poterti giustificare, perché se ora soffri e piangi hai un valido motivo, grande quanto le ingiustizie del mondo. Gridalo bimba. Ti prenderanno per matta, avrai un baratro di distanza fra te ed il resto, ma non importa, tu segnalo, incidilo, registralo, scrivilo, per non dimenticarlo, per non seppellirlo insieme alle tante morti con cui ti sei tumulata, fa che la voce ritorni come dall’oltretomba all’udire di miliardi di vite, finte illusioni d’esistenza, morti con te per le stesse ragioni, vivi come te nelle prigioni del silenzio.
Pubblicato: lunedý 6 giugno 2011
Alle ore: 16:53:58
Alle ore: 16:53:58